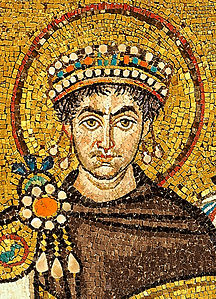Gli ultimi due post (questo e questo) li abbiamo dedicati al sogno di una torre di Babele che è duro a morire, perché dura a morire è una volontà di sfida che la creatura lancia al creatore. Sogno e bisogno antico, tanto che la Bibbia ci narra di Nimrod, colui che fu l’artefice della Torre di Babele.
Gli ultimi due post (questo e questo) li abbiamo dedicati al sogno di una torre di Babele che è duro a morire, perché dura a morire è una volontà di sfida che la creatura lancia al creatore. Sogno e bisogno antico, tanto che la Bibbia ci narra di Nimrod, colui che fu l’artefice della Torre di Babele.
Essa fu realtà o mito? la Bibbia narra l’episodio pescando dal suo fantastico o riporta una fantastica realtà di fatti? Sinora, credo, tutti siano concordi nell’affermare che è la realtà, sì, ma la realtà del mito per cui Babele è solo sinonimo di confusione e nient’altro.
Tuttavia, al di là del mito o della realtà, c’è un modo per venire a capo della questione: farsi umilmente due conti alla luce di una cronologia che sinora non ci ha tradito: la nostra, capace, spesso, di venire a capo di questioni ben più spinose di una torre, per quanto famosa.
Infatti, noi abbiamo a suo tempo affrontata la genealogia lucana, raccolta nell’omonima categoria, e siamo giunti, ricorrendo a un copia e incolla, alla conclusione che:
- Adamo/Nochè (3923 A.M-2863 A.M) per un totale di 10 generazioni, per cui (3923-2863) : 10 = 106, cioè una generazione conta 106 anni.
- Per il periodo Nochè-Abramo (2863 A.M.-1975) 888 anni (888 ghematria di Ἰησοῦσ, lo abbiamo visto qui) diviso le dodici generazioni che intercorrono dà che ogni generazione segna 74 anni esatti.
- Per il periodo Abramo-Davide (1975 a.C.-989 a.C.) 17 generazioni, comprendenti anche il ramo materno, per un totale 986 anni che segna per ciascuna generazione di 58 anni esatti.
La lista comprenderebbe anche il periodo Davide-Gesù, ma non è importante al momento, perché tutto si svolge da Davide ad Adamo.
Adesso è importante citare wiki, che a sua volta cita il Libro dei Giubilei, in cui si legge che fu con il Patriarca Ragau che s’iniziò la costruzione della Torre di Babele. La notizia è scarna, quasi un’eco perché non offre nessun modo per datare l’evento.
Noi, però, siamo in possesso delle coordinate cronologiche necessarie per farlo, perché quel Patriarca è compreso nella genealogia lucana, esattamente quattro generazioni prima di Abramo procedendo da Adamo come si può vedere. Infatti
Sapendo già (vedi sopra) che una generazione da Davide ad Abramo conta 58 anni esatti e sapendo che Davide fu unto re nel 989 a.C. otteniamo che le 17 generazioni comprese nella tranche genealogica danno un ammontare di 986 anni che sommati al 989 a.C. indicano la generazione di Abramo nel 1975.
Poi, sapendo che da Abramo a Ragau corrono 4 generazioni di 74 anni, sommeremo al 1975 296 anni per ottenere il 2271 a.C. generazione di Ragau, il Patriarca che iniziò i lavori alla torre stando al Libro dei Giubilei. Adesso, quindi, siamo in grado di conoscere l’anno in cui la costruzione della torre ebbe inizio, sebbene con una datazione che oscilla tra il 2271 a.C. e il 2197 a.C.
Della Torre di Babele ce ne siamo già occupati in un post che proponemmo quasi per gioco il cui risultato, però, ci sorprese in quanto coincidente con gli studi di Fernand Crombette, che molti conoscono. Infatti noi sommammo, per gioco, i capisaldi dell’attuale cronologia dei Re con il primo anno di regno di Ciro, datazione assoluta, sommammo cioè 1031+587+559 quando la prima cifra indica il primo anno di regno di Saul; la seconda la fine della dinastia davidica (esilio babilonese) e la terza il primo anno di regno di Ciro.
Queste date sono il caposaldo accademico per la storia del Vicino Oriente Antico e non sono nostre. Ecco, la loro somma ammonta a 2177 che è, nell’ottica di una datazione doppia (2177/2178), perfettamente coincidente a quanto a suo tempo ha affermato Crombette per la costruzione della Torre di Babele (2178 a.C.), quando invece, come vedremo, è più opportuno dire che fanno luce sulla sua distruzione e l’insorgere della Babele delle lingue, come narra la Bibbia
Infatti abbiamo che se togliamo al 2271 a.C., anno della generazione di Ragau, Patriarca che dette inizio ai lavori alla torre, il 2178 a.C. otteniamo che passa poco più di una generazione se le generazioni tra Abramo e Noè (Nochè) si compongono di 74 anni esatti, come abbiamo illustrato sopra. Infatti 2271-2178=94 e questo colloca quel 2178 indicato da noi e da Crombette nella generazione di Seruc, esattamente nel ventesimo anno di quella generazione.
Questo è molto importante perchè significa che i nostri calcoli non vanno oltre la sequenza descritta dal Libro dei Giubilei che indica in Ragau il fondatore della torre; in Seruc il suo crollo, per cui quei 94 anni di differenza che si generano tra il calcolo generazionale (2271) e il calcolo fatto da Crombette e noi ((2178/77) rispettano, non sforando le due generazioni di Ragau e Seruc, l’ordine dei fatti descritto dai Giubilei.
Infatti, come abbiamo consigliato di leggere wiki per Ragau, adesso consigliamo la lettura, aprendo il link (vedi sopra), di Seruc , dove si legge che nella sua generazione avvenne la confusione delle lingue di cui parla la Bibbia. Infatti è proprio in Seruc che la confusione prende corpo, perché il suo nome proprio conduce a un “gioco di parole intraducibile”, come scrive wiki, tanto che s’incolpa un fonema, ma in realtà quel gioco di parole intraducibile tradisce e traduce quanto in realtà accadde a Babele in quegli anni, quando ” Ora, figlia di Ur e nipote di Kesed,…gli mutò il nome originale Seruh in Serug” testimoniando una confusione delle lingue, tanto che ne fece le spese Saruc stesso di cui, a tutt’oggi, non sappiamo dare ragione neppure del suo nome.
Non è solo, quindi, una sequenza di calcoli che individuano se non un anno certamente una generazione, ma è la sequenza di generazioni (Ragau-Seruc) che conferma, alla luce del Libro dei Giubilei, quanto accadde all’ombra della Torre di Babele. Quel 2178/77 a.C individuato da Crombette e da noi cadono in un contesto che prima si fa cronologico (generazionale); poi genealogico e infine s’inseriscono tra le pagine del Libro dei Giubilei la cui narrazione conferma tutto.
Non siamo in grado di dire con esattezza quando la costruzione della torre ebbe inizio, ma siamo certi della sua fine, come certo fu Crombette giunto alla nostra stessa conclusione: il 2178/2177 a.C. l’anno in cui Babele crollò non sotto il peso della sua portata, ma a causa del numero delle lingue che la costruivano.
Noi ci siamo arrivati sommando i capisaldi della cronologia attuale del Vicino Oriente Antico, quella che da sempre denunciamo assolutamente falsa, tanto che se Saul è il capostipite della cronologia dei Re, segnata alla sua fine nel 587 a.C., siamo in grado di dire che, data la sua assoluta falsità, nessun altro poteva esserne re che Ciro, quel Ciro necessario alla somma che compone il 2177 (1031+587+559=2177). Solo lui poteva essere re in una cronologia frutto della menzogna più spudorata. Ma non è una novità.
Casomai è una novità che quel sogno folle di conquista del cielo non sia svanito, perché il mondo accademico, diffondendo quella cronologia assolutamente falsa, partecipa del sogno di Nimrod e con esso parteciperà alla sua rovina. Un sogno folle che si tramuterà in incubo, perché il protagonista è colui che, se letto a rovescio, si presenta come dormi(N) e lo sappiamo da Einstein che “il sonno della ragione genera mostri” , curiosamente titolo del tema della mia maturità, che a ormai cinquantatré anni vorrei sostenere di nuovo, visti gli argomenti e la maturità, cose che mi farebbero concludere il tema con un laconico: “E’ vero, proprio vero, chapeau!”
 Un errore sarebbe forzare i numeri, mentre è giusto trovare in essi le relazioni nascoste ma solo se osservate nel particolare, perché una cronologia, se tale, cioè di respiro, è sempre universale e si rivela alla distanza.
Un errore sarebbe forzare i numeri, mentre è giusto trovare in essi le relazioni nascoste ma solo se osservate nel particolare, perché una cronologia, se tale, cioè di respiro, è sempre universale e si rivela alla distanza.
 Parlare dei Padri del deserto mi serve, mi serve perché introducono in un mondo ben oltre quello di Carroll che ci ha descritto la meraviglia, sebbene sia ancor più meraviglioso comprendere il dramma di un’epoca nelle pochissime righe di apoftegma come nel caso di
Parlare dei Padri del deserto mi serve, mi serve perché introducono in un mondo ben oltre quello di Carroll che ci ha descritto la meraviglia, sebbene sia ancor più meraviglioso comprendere il dramma di un’epoca nelle pochissime righe di apoftegma come nel caso di